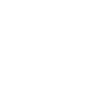World Alzheimer’s day, in Italia 1,2 milioni di casi di demenza: le attività dell’Iss, dall’Osservatorio Demenze agli studi dei meccanismi della memoria

UFFICIO STAMPA
Back World Alzheimer’s day, in Italia 1,2 milioni di casi di demenza: le attività dell’Iss, dall’Osservatorio Demenze agli studi dei meccanismi della memoria
Il 21 settembre viene celebrato in tutto il mondo il World Alzheimer's Day, uno sforzo globale per aumentare la consapevolezza e combattere lo stigma intorno a questa e ad altre forme di demenza. L’Istituto Superiore di Sanità si occupa di questi temi sotto diversi aspetti, dalle attività dell’Osservatorio Demenze, tra cui la mappatura dei centri dedicati alla malattia, alla ricerca sperimentale portata avanti dal dipartimento di Neuroscienze.
Cos’è la demenza
Il termine demenza indica una condizione clinica di natura cronico-degenerativa, vascolare, metabolica o infiammatoria, che si presenta dunque in diverse condizioni patologiche primarie e secondarie. La storia naturale della demenza è caratterizzata dalla presenza di deficit cognitivi progressivi (memoria, linguaggio, funzioni esecutive e prassiche, astrazione), disturbi del comportamento e danno funzionale, con perdita dell’autonomia fino alla completa dipendenza dagli altri. Rappresenta quindi una delle maggiori cause di disabilità.
Si stima oggi che in Italia vi siano circa 1.200.000 casi di demenza nella fasca d’eta uguale o superiore ai 65 anni e circa 24.000 casi di demenza giovanile compresi nella fascia d’età 35-64 anni. Inoltre è possibile stimare in circa 950.000 le persone con Mild Cognitive Impairment, un condizione che talvolta precede l’inizio della demenza. Se si considera che accanto a queste 2.200.000 persone con un disturbo cognitivo vivono circa 4 milioni di familiari è possibile stimare che circa il 10% della popolazione italiana si trova ad affrontare questo probelma (Report Nazionale Fondo Alzheimer e demenze 2021-23, ISS).
Il costo complessivo della demenza è stato stimato in 23 miliardi di euro l’anno di cui il 63% a carico delle famiglie.
Il principale fattore di rischio non modificabile associato alla demenza è l’età ma vi sono ad oggi 14 fattori di rischio modificabili (basso livello di istruzione, ipertensione, ipoacusia obesità, fumo, depressione, inattività fisica, diabete, scarse relazioni sociali, eccessivo consumo di alcol, esposizione all’inquinamento atmosferico,traumi cerebrali, deficit visivo non trattato e alti livelli di colesterolo LDL) che possono consentire di ridurre fino al 45% i casi di demenza (Lancet Commission 2024). Inoltre va segnalato che alcune mutazioni genetiche sono responsabili di forme rare a trasmissione autosomica dominante.
Scopri qui i 10 segnali della malattia di Alzheimer (https://www.demenze.it/it-schede-44-i_10_segnali_di_allarme_della_malattia_di_alzheimer)
“Al contrario degli stereotipi che si sono formati nei decenni passati, l’esperienza delle demenze ormai non si riduce alla malattia – spiega Nicola Vanacore, responsabile dell’Osservatorio -. È un mondo intero che ingloba la soggettività dei pazienti e il loro rapporto con i familiari, i caregiver, i medici, le associazioni e le istituzioni. È un percorso in espansione che implica vari attori sociali e culturali, impegnati nella condivisione e nella relazione di cura, basata su competenze multidisciplinari, per far sì che il paziente sia ascoltato e seguito in tutte le fasi della malattia”.
Le attività dell’Osservatorio Demenze
L’Osservatorio contribuisce a promuovere e valutare politiche di prevenzione e di adozione di programmi integrati della demenza, attraverso la partecipazione a tavoli istituzionali, ad attività di ricerca in sanità pubblica e internazionale. Si occupa tra le altre cose delle attività legate all’implementazione del Piano Nazionale Demenze e del Fondo per l’Alzheimer e le demenze e della mappa dinamica online dei servizi dedicati. Per quanto riguarda le attività del piano nazionale, tra i traguardi raggiunti, recentemente descritti anche da un articolo pubblicato su BMJ Public Health, ci sono un’analisi nazionale e regionale delle politiche di prevenzione primaria della demenza, tre survey nazionali sull’organizzazione dei nodi assistenziali della rete per la demenza, un’indagine su oltre 2.300 caregiver di persone con demenza, che ha permesso di approfondire le condizioni socioeconomiche delle famiglie e le differenze territoriali nell’accesso a diagnosi, cure e servizi socio-assistenziali. È stata redatta e pubblicata sul Sistema Nazionale Linee Guida inoltre la prima Linea Guida Nazionale su diagnosi e trattamento di demenza e Mild Cognitive Impairment. Per quanto riguarda la mappatura dei servizi dedicati alle demenze, l’Osservatorio ha censito 511 Centri per i disturbi cognitivi (223 al nord, 102 al centro e 186 al sud), 1671 Rsa (1157 al nord, 368 al centro, 146 al sud) e 443 centri diurni (307 al nord, 87 al centro e 49 al sud).
La ricerca sull’Alzheimer in Iss: due domande a Daniela Merlo, direttrice del dipartimento di Neuroscienze
La ricerca di un farmaco contro l'Alzheimer ha portato negli ultimi anni a molte più delusioni che successi. Qual è la situazione attuale? Ci sono farmaci approvati? E in sviluppo?
Negli ultimi mesi l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), suscitando opinioni contrastanti, ha dato parere positivo all’approvazione di lecanemab e donanemab, due anticorpi monoclonali diretti contro la proteina amiloide, per i pazienti con Mild Cognitive Impairment (MCI, o Disturbo Cognitivo Lieve) e demenza di Alzheimer lieve. Si tratta di una terapia che ha mostrato efficacia nel rimuovere l'amiloide dal cervello ma con effetti clinici da verificare solo in pazienti con presenza documentata di amiloide nel cervello, identificata con esami specifici come la PET o l’analisi di biomarcatori in fluidi biologici. Non è invece adatta a chi si trova in fase avanzata o presenta altre patologie, come l’encefalopatia vascolare, né a chi assume anticoagulanti, né ai pazienti omozigoti per il gene ApoE 4, per il rischio di microemorragie cerebrali.
Il punto cruciale resta la diagnosi precoce: gli strumenti necessari sono costosi o invasivi e non sempre disponibili, ma sono fondamentali per selezionare correttamente i pazienti, soprattutto considerando il costo molto elevato di queste terapie. Bisogna anche ricordare che non tutti i soggetti con lieve deterioramento cognitivo (MCI) sviluppano la demenza e che la presenza di amiloide può essere rilevata anche in persone senza sintomi.
Accanto alle terapie dirette contro l’amiloide, si stanno esplorando nuove possibili strade, tra cui le cosiddette ‘Tau targeting therapies’, cioè terapie mirate alla proteina Tau. Si stanno inoltre esplorando strategie alternative rispetto a queste più ‘tradizionali’. Ad esempio uno studio, ancora preliminare, effettuato su topi e su tessuti umani ma non su pazienti, condotto dalla Harvard Medical School e pubblicato su Nature lo scorso agosto, ha individuato un legame tra i livelli di litio nel cervello e lo sviluppo dell’Alzheimer. I ricercatori hanno osservato che una carenza di litio è associata a una maggiore formazione di placche amiloidi e a una progressione più rapida della malattia, mentre livelli adeguati sembrano avere un effetto protettivo contro la neurodegenerazione. Una prospettiva interessante.
Le attività del Dipartimento di Neuroscienze su questo tema sono soprattutto orientate allo studio dei meccanismi della memoria. Quali sono le implicazioni anche sull'Alzheimer?
L’Alzheimer è una malattia molto complessa e non potrà essere affrontata con un unico approccio. Ad oggi non esistono farmaci risolutivi e solo la ricerca potrà condurci a soluzioni più efficaci. Per questo è fondamentale approfondire i meccanismi cellulari che regolano la formazione e il mantenimento della memoria, così da capire meglio le cause della sua perdita. Proprio in questa direzione si inserisce un nostro studio, pubblicato recentemente su EMBO Reports. Abbiamo scoperto che l’accumulo di beta-amiloide può ridurre l’attività dell’enzima DNA-PKcs e di conseguenza abbassare i livelli di proteine fondamentali per l’organizzazione delle sinapsi, come la proteina PSD-95. Questo processo compromette le connessioni neuronali e contribuisce al declino cognitivo. La scoperta è importante perché suggerisce nuove vie cellulari che potrebbero essere modulate farmacologicamente.