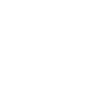Interazione tumore/ospite
Negli ultimi decenni è emersa con sempre maggiore chiarezza l’importanza dell’interazione tra il sistema immunitario e i tumori. Se il sistema immunitario cerca di prevenire e frenare lo sviluppo tumorale tramite il riconoscimento di strutture specifiche delle cellule neoplastiche, queste ultime escogitano espedienti per evadere tale controllo e crescere indisturbate.
Uno di questi è l’utilizzo di una molecola chiamata PD-L1 che normalmente è espressa da altre cellule del sistema immunitario con la funzione di legare un recettore dei linfociti chiamato PD-1 e in questo modo sopprimere la risposta immunitaria. Si tratta quindi di un meccanismo benefico che il sistema immunitario utilizza per impedire risposte incontrollate e deleterie, particolarmente utile quindi per prevenire l’autoimmunità, ma che il tumore sfrutta a proprio vantaggio attraverso l’espressione anomala di PD-L1.